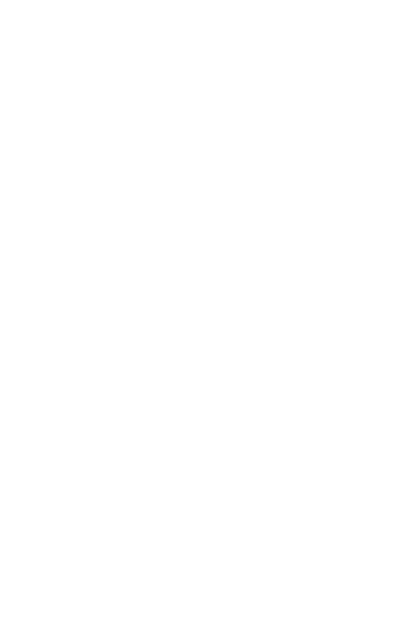Che cos’è il dolore?
Viene definito come «un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata, o simile a quella associata,
a un danno tissutale reale o potenziale» dall’associazione internazionale per lo studio del dolore (IASP).1
Sempre secondo IASP, per spiegare cosa sia il dolore non ci si deve limitare a questa definizione,
ma occorre prendere in considerazione altri aspetti.1
- Il dolore è sempre un’esperienza personale, il che significa che può influenzare diversamente il nostro corpo (la sfera biologica), la nostra mente (la sfera psicologica) e il modo in cui ci rapportiamo agli altri (la sfera sociale);
- Il modo in cui percepiamo il dolore è un fenomeno diverso dal dolore stesso.
- Si impara cosa sia il dolore durante il corso della vita;
- Chi manifesta e riporta di aver vissuto un’esperienza dolorosa merita rispetto;
- Sebbene il dolore abbia di solito un ruolo adattativo, permettendo di adattarsi all’ambiente circostante, può avere anche effetti indesiderati sulla funzionalità e sul benessere psicologico e sociale;
- La descrizione verbale rappresenta una delle diverse modalità di espressione del dolore: chi non è in grado di comunicarlo non significa che non possa viverlo.
Come possiamo classificare il dolore?
Il dolore può essere estremamente variabile in termini di intensità, qualità e durata e può avere diversi
meccanismi e significati.1
Tipologie di dolore in base all’ORIGINE

In base al meccanismo che dà origine al dolore, dal punto di vista medico esiste una classificazione definita patogenetica che distingue tre diversi tipi di dolore: nocicettivo, neuropatico e nociplastico.2
- Il dolore nocicettivo è dovuto all’infiammazione o a un danno di una specifica parte del corpo.2
In tale regione, gli stimoli attivano i recettori del dolore, che segnalano il danno e indicano la posizione in cui è avvertito. Può avere un’origine superficiale o profonda.2
Esempi classici: osteoartrosi, artrite reumatoide, dolore da cancro.2 - Il dolore neuropatico è causato da una lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale
(ovvero il sistema coinvolto nella trasmissione degli impulsi dolorosi3 ) centrale e/o periferico.2
Si distingue in periferico e centrale, in base alla sede della lesione.2
Esempi classici: dolore da neuropatia diabetica, nevralgia post-herpetica.2 - Il dolore nociplastico è caratterizzato da un disturbo nell’elaborazione del dolore che provoca sintomi dolorosi non precisamente localizzabili.2
Nel 2016 IASP lo ha definito come “un dolore che non mostra nessuna chiara evidenza di danno effettivo
o potenziale o di malattia o lesione del sistema somatosensoriale nocicettivo”.2 Esempi classici: fibromialgia, sindome del colon irritabile, disfunzione temporomandibolare, cefalea muscolo-tensiva.2
Tipologie di dolore in base all’INTENSITÀ
L’intensità rappresenta un parametro fondamentale per una corretta valutazione del dolore.3
A questo fine, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito una scala graduata di classificazione del dolore in base all’intensità nota con la sigla NRS: Numerical Rating Scale3

Inoltre, per rendere più completa la misurazione del dolore e il suo impatto sulla vita di chi ne soffre è utile misurare: 3
- la tollerabilità: molto tollerabile, tollerabile, poco tollerabile, insopportabile
- i problemi a svolgere le attività quotidiane: nessuno, pochi, qualche volta, molti, da non riuscire a fare niente
Tipologie di dolore in base alla DURATA

Il dolore acuto è un dolore di breve durata che corrisponde a un danno tissutale: è finalizzato ad allertare il corpo sulla presenza di stimoli pericolosi o potenzialmente tali nell’ambiente e nell’organismo stesso.
Si esaurisce quando cessa l’applicazione dello stimolo o si ripara il danno che l’ha prodotto.3
Il dolore persistente è un dolore dovuto alla permanenza o alla ricorrenza dello stimolo doloroso.
Questo tipo di dolore conserva le caratteristiche del dolore acuto e va distinto dal dolore cronico.3
Il dolore cronico è un dolore che persiste per più di 3 mesi e/o si mantiene nonostante la guarigione della causa
che l’ha scatenato. Con il termine dolore cronico vengono definiti quei casi in cui, dopo una lesione o malattia iniziale, si generano alterazioni biologiche, psicologiche e sociali che rendono complessa l’identificazione della causa iniziale.
Il dolore non è più solo un sintomo, ma diventa “malattia”.3
La probabilità che il dolore acuto si trasformi in dolore cronico varia da persona a persona. È di fondamentale importanza gestire adeguatamente il dolore nella fase acuta per evitare che cronicizzi. L’identificazione precoce consente di intervenire tempestivamente.4
- Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain. 2020;161(9):1976-1982.
- Coluzzi F, Marinangeli F. Basic pain support. Le basi della medicina del dolore. Carocci editore. 2021. ISBN 8874668546
- Magni A, et al. Classificazione e inquadramento del paziente con dolore non oncologico. Rivista Società Italiana di Medicina Generale. 2016;5:50-54
- Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines group. Evidence-based management of acute musculoskeletal pain. 2003
https://www.cdha.nshealth.ca/system/files/sites/122/documents/based-management-acute-musculoskeletal-pain.pdf
Anche una cicatrice può far male. In alcuni casi è un dolore solo fisico, in altri è legato a ricordi da dimenticare. La Dott.ssa Fulvia Gariboldi, fisiatra, ci spiega come approcciarsi di fronte a questa particolare problematica e quali sono le terapie a disposizione.
Il tratto cervicale e il tratto lombare sono le due sedi della colonna vertebrale di maggior movimento e, di conseguenza, più sottoposte a insorgenza di dolore. La fisiatra Fulvia Gariboldi ci spiega come ci si pone davanti ad un paziente che presenta questi sintomi e quali sono le terapie che possono essere intraprese per alleviare il dolore.
La life coach Lucia Di Palermo ci spiega qual è la strategia migliore per raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati. La strategia è un insieme di azioni e decisioni pianificate a monte, importanti per creare una routine e darci delle certezze.
La Dott.ssa Lucia Di Palermo, life coach, ci spiega come approcciarsi al cambiamento della nostra vita di fronte al dolore cronico. È importante dare significato a quello che ci sta accadendo e trasformarlo in qualcosa che migliori la nostra qualità di vita e soprattutto il nostro tempo.
Capire come funziona la percezione del dolore e la sua percezione nella forma cronica è molto importante per cercare di non limitare la propria vita. La dott. Maura Levi, psicologa clinica, in questo video ci spiega con parole semplici questo complicato meccanismo e come sia importante chiedere aiuto per preservare la propria qualità di vita.
Il dolore cronico incide negativamente sul tono dell’umore e può generare importanti stati d’ansia. Ma, a loro volta, queste alterazioni emotive possono aggravare la percezione del dolore. Nel video la dott. Maura Levi ci spiega perché questo si verifica e come affrontare le relative problematiche.
Il dolore cronico è totalizzante e ci fa perdere la voglia di fare e la fiducia nelle nostre capacità. Scegliere un obiettivo da raggiungere ci aiuta a ritrovarla e a restare in contatto con noi stessi.
Ma, come si sceglie un obiettivo? Bisogna innanzitutto guardarsi dentro, ascoltare le emozioni e scegliere qualcosa che ci faccia stare bene e che sia sorretto da una forte motivazione. L’obiettivo deve essere formulato in maniera chiara, precisa e con termini positivi. Inoltre, deve essere specifico, misurabile e raggiungibile in un determinato lasso di tempo.
Una volta individuato l’obiettivo, si devono pianificare le strategie per raggiungerlo e bisogna farlo in modo che siano efficaci per noi e per il nostro modo di vivere il dolore. Si possono, ad esempio, prefissare dei mini-traguardi da conquistare quotidianamente che, concatenati l’uno all’altro, costituiranno gli step che ci porteranno all’obiettivo finale.
Perché tutti questi passaggi sono fondamentali? Perché obiettivi non raggiungibili o non adatti a noi, ci fanno perdere la concentrazione, ci tolgono energie e autostima e non ci aiutano a convivere in maniera adeguata col nostro dolore.
L’unico modo per restare concentrati senza farsi travolgere e dominare dalle emozioni negative è quello di imparare a conoscerci, scegliendo di volta in volta traguardi adatti a noi e alla nostra vita. Ci sono tanti modi per iniziare a comprendere fino in fondo chi siamo e come funzioniamo.
Uno dei più semplici, e alla portata di tutti, è sicuramente la lettura. Chi non sa da dove partire, può, ad esempio, iniziare con la trilogia dei libri di Krishnananda (è lo pseudonimo dello psichiatra americano Thomas Trobe). “A tu per tu con la paura”, “Uscire dalla paura” e “Fiducia e sfiducia” sono tre testi che, partendo dall’esperienza personale dell’autore, aiutano a entrare in contatto con sé stessi e a liberarsi dal dominio delle paure che ci impediscono di vivere a pieno la nostra vita.
BIBLIOGRAFIA
- Krishnananda, Amana: Fiducia e sfiducia, imparare dalle delusioni della vita; Milano, Feltrinelli Editore; ed 2021
- Krishnananda, Amana: A tu per tu con la paura, vincere le proprie paure per imparare ad amare; Milano, Feltrinelli Editore; ed agosto 2021
- Krishnananda, Amana: Uscire dalla paura, osservare il bambino emozionale dentro di noi e interrompere l’identificazione; Milano, Feltrinelli Editore; ed luglio 2020
Il dolore cronico stravolge il nostro modo di vivere. Possiamo subirlo, giudicandolo e cercando di accettare ciò che ci accade, oppure possiamo usare il potere che abbiamo sul nostro tempo e sulla nostra vita, per dare un nuovo significato a quello che siamo e a quello che facciamo.
Il dolore non è buono o cattivo. Semplicemente c’è. È vero, ha trasformato il nostro modo di vivere la quotidianità e ha cambiato il modo in cui gestiamo il tempo delle nostre giornate. E, a volte, ci fa provare la spiacevole sensazione di non avere più il controllo sulla nostra vita. Ma è anche vero che siamo noi ad avere il potere di dare un senso alle cose e al nostro tempo.
La differenza tra subire il dolore e scegliere come gestire ciò che ci accade, si trova tutta in un unico principio che dobbiamo sempre ricordare: non è quello che ci capita a definire chi siamo, ma siamo noi ad attribuire significato e valore alle cose. Vivere una situazione di dolore permanente non è semplice ma non rappresentare la fine di ciò che siamo. Perché? Perché la nostra vita è cambiata e il tempo delle nostre giornate è scandito da questo cambiamento. Se impariamo a riconoscere che il tempo è un assegno in bianco che ci viene consegnato la mattina e scade la sera, e se teniamo ben presente che siamo noi che gli attribuiamo qualità, allora possiamo riprendercelo e possiamo attribuirgli un nuovo valore. All’interno di questo tempo possiamo decidere di ritagliarci uno spazio tutto nostro, compatibile col nostro modo di convivere con il dolore, per realizzare un piccolo o un grande progetto che ci aiuti a riprenderci il controllo sulla nostra vita e che ci restituisca il potere di decidere come viverla.
BIBLIOGRAFIA
- Giorgio Nardone, Problem solving strategico in tasca. L’arte di trovare soluzioni a problemi irrisolvibili; ed Feltrinelli; ed 2009
- Matteo Motterlini, Trappole mentali; Ed Rizzoli; ed 2008
- Daniel Goleman, Intelligenza Emotiva, cos’è e perché può renderci felici; ed: Rizzoli; ed 1995
Il dolore cronico può portarci a perdere il contatto con noi stessi e può privarci della nostra autostima. Un obiettivo che abbia un senso, che sia sorretto da una buona motivazione, e che sia raggiungibile, ci aiuta a ritrovare la fiducia in noi stessi e in ciò che siamo. Perché? Perché quando fissiamo un obiettivo da raggiungere, che ci piace e che ci appartiene, diventiamo più tenaci e determinati, ricominciamo a credere in noi stessi e usiamo le nostre energie e la nostra creatività per raggiungere il nostro scopo e per superare le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino. Se un obiettivo ci appartiene davvero, per raggiungerlo, diventiamo automaticamente predisposti a concentrarci, a pianificare e a eseguire compiti e strategie entro un termine che abbiamo prefissato e prestabilito.
Il tempo è la variabile che distingue gli obiettivi a breve termine, da quelli a medio e lungo termine. Quelli a breve termine, in particolare, sono dei mini-traguardi che possiamo raggiungere quotidianamente e che, step by step, ci permetteranno di riacquistare fiducia in noi e nelle nostre capacità. Ogni volta che conquistiamo un risultato dobbiamo sempre celebrarlo e dargli il giusto riconoscimento. Ma, soprattutto, dobbiamo ringraziare noi stessi perché ce l’abbiamo fatta.
Quando scegliamo i nostri obiettivi dobbiamo prestare molta attenzione alle sensazioni che ci provocano. Dobbiamo imparare a leggere le nostre emozioni, soprattutto quelle connesse al dolore, a riconoscerle, a dare loro un nome e a interagire con loro. Perché? Perché se le conosciamo non saranno più loro a dominarci ma saremo noi a riconoscerle e a farle diventare funzionali per il raggiungimento dei nostri scopi.
Darci un obiettivo è un’azione che compiamo sul piano del fare ma che si ripercuote sul piano dell’essere. Nel momento in cui ci crediamo e siamo motivati nel raggiungerlo, riusciamo a recuperare la nostra autostima e la fiducia nelle nostre capacità.
BIBLIOGRAFIA
- Susan David; Agilità emotiva; non restare bloccato, accogli il cambiamento, Firenze; Giunti Editore; ed 2016.
- Daniel Kaneman, Pensieri lenti pensieri veloci; Cles (TN) ; Arnoldo Mondadori Editore; ed 2013
- Patrice Ras, L’arte di ascoltare; Lavis (TN), ed: il punto d’incontro, ed 2016